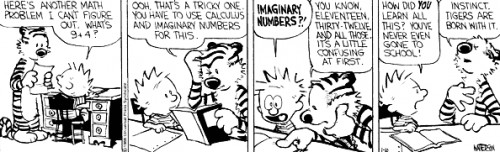Prima intervista ad Amalia Signorelli
Le violenze prima. La strumentalizzazione poi. Perché l'uomo occidentale difende le donne «per sentirsi superiore ai musulmani».
Dalla open society alla fear society. Dalla società aperta che rende libere le facoltà critiche della persona a quella della paura, che in silenzio perde ogni giorno le libertà conquistate.
Dalle donne nude sui manifesti per sponsorizzare uno yogurth a quelle velate e rinchiuse in casa per difendere il focolare domestico, sino ad arrivare a quelle molestate e violentate nella centrale piazza di Colonia durante la notte di San Silvestro.
LA GUERRA DELL'UOMO OCCIDENTALE.
Più che l'ennesimo scontro di civiltà, quello che si consuma sul corpo femminile è uno scontro tra uomini.
«L'uomo occidentale, che esercita la sua superiorità su quello musulmano, o almeno tenta di esercitarla. E non certo per difendere le donne, ma il proprio potere», spiega a Lettera43.it l'antropologa Amalia Signorelli.
Ma essendoci apparentemente in ballo 'solo' la dignità femminile, nei giorni dopo le violenze di Capodanno si è sentito solo tanto silenzio.
Quello delle forze dell'ordine di Colonia prima di tutto, che non sono intervenute davanti a quello che poi lo stesso rapporto della polizia ha definito «l'attraversamento delle forche caudine» per oltre un centinaio di donne. Un atto progettato da una banda che avrebbe addirittura più di un migliaio di adepti, e che era nota agli inquirenti tedeschi da oltre 18 mesi. Eppure nessuno ha fatto niente
IL SILENZIO E LA MANCANZA DI DIRITTI.
Così come nessuno fa niente quando si legge che le donne in Italia guadagnano sei mila euro di pensione in meno rispetto agli uomini, che a parità di ore lavorate hanno stipendi più leggeri, che rivestono sì ruoli amministrativi e politici, ma quasi sempre al fianco di colleghi maschi che tengono il comando.
«Purtroppo ora anche le donne hanno iniziato a stare in silenzio», dice Signorelli, non senza tradire un pizzico di sconforto.
Amalia Signorelli, antropologa e sociologa
Colonia Signorelli: "A Colonia una guerra tra maschilisti"
08 Gennaio 2016, Antonietta Demurtas per L43
DOMANDA. Da cosa nasce questo silenzio?
RISPOSTA. C'è una paura diffusa che non è solo legata agli attentati e alle violenze, ma è più generale, ed è cominciata prima. C'è la preoccupazione di non esporsi troppo, di non farsi dare della femminista, dell'aggressiva.
D. Quella che vuole 'rubare' il potere all'uomo?
R. Forse dovremmo arrenderci all'idea o prendere atto che la storia dell'uomo solo al comando è un eufemismo per parlare di società che diventano sempre più centralizzate e autoritarie sulle materie che contano, lasciando poi un grandissimo margine di pseudolibertà sulle materie irrilevanti.
D. Ma andare controcorrente oggi non è così semplice...
R. Il non conformismo si paga caro e questo potrebbe avere inciso sui comportamenti pubblici di un po' di tutti, non solo delle donne, basta vedere cosa succede a livello politico.
D. Lei cosa vede?
R. Oggi chi fa il parlamentare in Italia non lo fa più per difendere le proprie idee, ma la propria carriera e ciò significa andare a chiedere l'appoggio laddove è meglio pagato, un orientamento diffuso generale sul quale ci sarebbe molto da riflettere e preoccuparsi, a partire dai riscontri oggettivi.
D. Per esempio?
R. Le riforme o le cosiddette 'schiforme', che vanno tutte in una direzione di centralizzazione delle decisioni e progressiva dipendenza da un'autorità che non è messa in discussione. Anche questa nuova figura del preside sceriffo è un segno.
D. Un'accentuazione del superuomo visto che sono ancora gli uomini a comandare. E a violentare...
R. Sui fatti di Colonia sono molto perplessa: non ho ancora capito che cosa sia successo veramente. Ci sono troppe notizie contradditorie e interpretazioni discutibili.
D. In che senso?
R. La violenza è da condannare, ma adesso, siccome dobbiamo dire tutti che il mondo islamico fa schifo, e per certi versi è anche vero, per avvalorare questa tesi vengono tirate in ballo le donne. Tutto perché gli uomini occidentali sono convintissimi di due cose.
D. Quali?
R. Di averci dato loro la libertà e la parità, di avercela gentilmente concessa e per questa ragione di essere infinitamente superiori ai loro colleghi musulmani. Due balle colossali.
D. Perché?
R. Prima di tutto perché quel tanto che le donne occidentali hanno è frutto delle lotte femminili. Anche se la parità vera non l'abbiamo ancora raggiunta, c'è un riconoscimento nell'esercizio dei diritti, una base di partecipazione sociale abbastanza paritaria.
D. Quindi secondo lei più che scontro di civiltà siamo ancora allo scontro tra uomini, quello occidentale che esercita la sua superiorità su quello musulmano?
R. Più che esercitarla, tenta di esercitarla. E non certo per difendere le donne, ma solo il proprio potere. Come in altri casi ci hanno fatto fare la bandiera della loro capacità di repressione, ora ci fanno fare la bandiera della loro capacità di liberazione.
D. Che invece è un'autoliberazione.
R. Sì, noi i diritti li abbiamo perché ce li siamo presi. Son due secoli e mezzo che le donne occidentali si battono. Non è certo l'eroina più significativa, ma a titolo esemplificativo vorrei citare una donna come Angelina Merlin, di cui nessuno ora parla più.
D. Perché?
R. Ha avuto il coraggio di mettere il parlamento di fronte alla vergonga del sesso a pagamento pagato dallo Stato, le pare poco? E questa donna è stata derisa per tutta vita, messa ai margini della vita politica, anche se apparteneva a un partito socialista.
D. Gli uomini si sono vendicati così, emarginandola.
R. Salvo poi riconoscere che Merlin aveva ragione. Ma sono tante le donne che hanno fatto battaglie analoghe e anche più significative, davanti alle quali gli uomini hanno dovuto ingoiare il rospo.
D. Un rospo che ormai sembra abbiano digerito da tempo: le donne si sono arrese?
R. In effetti c'è un ritorno indietro da parte delle donne, una regressione. Ma soprattutto c'è un altro problema,
D. Quale?
R. Gli uomini non hanno mai fatto autocoscienza, non si sono mai chiesti, salvo pochissime eccezioni, che cosa vuol dire essere uomo, non hanno mai messo in discussione la tradizione aggressiva della loro sessualità.
D. E cosa hanno fatto, invece?
R. Hanno imparato che certe cose pubblicamente non le devono più dire e privatamente non le possono più fare con la libertà di un tempo. Ma non c'è mai stata una presa d'atto che la sessualità maschile è sempre predatoria anche nelle forme più addolcite.
D. Infatti ancora oggi il 60% delle violenze sulle donne viene compiuta dentro le mura domestiche.
R. D'altronde quando Silvio Berlusconi ha esibito in misura macroscopica la possibilità di mercificare i corpi femminili come voleva, purché uno abbia i soldi, ha trovato negli altri maschi italiani molta complicità.
D. Se non invidia...
R. Sì, al massimo in quelli che dovevano farlo per ragioni di ufficio c'è stata un po' di condanna moralistica, ma mai una presa di distanza, mai il coraggio di dire che l'amore prezzolato è qualcosa di infima categoria rispetto a quello spontaneo.
D. Non stupisce quindi che ancora oggi molti italiani sorridano ricordando la presunta battuta rivolta ad Angela Merkel, la «culona inchiavabile». Una donna capo di governo che noi chissà quando riusciremo ad avere...
R. Sì, ma se in un Paese come la Germania dove il presidente è donna, il sindaco di Colonia è donna, succedono le notti 'brave' come quelle di Capodanno, evidentemente la situazione non è così lineare.
D. Non basta ricoprire poltrone?
R. Pensa che il passaggio delle donne nel parlamento italiano da poche unità a un numero non disprezzabile abbia portato dei cambiamenti?
D. Che cosa manca ancora?
R. Una come Tina Anselmi per esempio. A quell'epoca le donne al potere erano davvero una minoranza schiacciata, oggi abbiamo più donne ma che non contano niente.
D. Maria Elena Boschi è ministro per le riforme costituzionali però.
R. La Boschi conta sino a quando Renzi la utilizza come copertura per fare certe operazioni. Il potere maschile mira ad autoconservarsi al massimo. Ed è abilissimo in queste operazioni.
D. Ora persino Salvini è diventato femminista e difende le donne violate dagli immigrati.
R. Dietro i fatti di Colonia c'è un di più che è esplicitamente politicante. L'impressione che sia tutto strumentalizzato per fini anti immigratori è chiarissima, e il sospetto che sia stata messa in scena per favorire una ondata anti migratoria non è del tutto gratuito.
D. Gratuito o meno sono comunque le donne a essere vittime. Eppure anche tra loro c'è stato un gran silenzio.
R. Non so cosa pensare, sono stata militante, ho costruito la mia vita in un'ottica femminista nel senso forte del termine ma da qualche anno mi ha impressionato molto l'atteggiamento tra le giovanissime, che ho conosciuto insegnando all'università.
D. Che cos'hanno queste ragazze che non va?
R. Danno per scontato che come stanno, stanno bene, che è inutile cercare di avere più di così, perché tanto il mondo non cambia e tutto sommato gli uomini le rispettano abbastanza. C'è un senso di arrendevolezza preoccupante.
D. Si sentono fortunate visto che non sono costrette a indossare un burqa...
R. Io non vorrei essere nata in un Paese musulmano, ma anche in Medio Oriente le ragazze vanno a scuola, si laureano con tutte le restrizioni e costrizioni, a Teheran ci sono medichesse, avvocatesse, giornaliste. Poi, certo, ci sono i veti dei regimi autoritari, censure per tutti. Ma la condizione femminile non è quella della schiava domestica, se non in parte minoritaria. E far sembrare che sia tutto così è solo una strumentalizzazione.
D. Dell'Occidente?
R. Sì, perché fa comodo l'immagine dell'uomo islamico che non vede l'ora di violentare una donna e per questo è inferiore all'uomo occidentale, che invece rispetta le donne. Sono in entrambi i casi due esagerazioni utili solo per la propaganda politica.
D. E in questo duello la donna che ruolo gioca?
R. Nessuno, perché oggi non riusciamo a organizzarci. I movimenti femministi di fine Anni 60-70 erano spontanei ma bene o male riuscivano a incontrarsi, creare dei collegamenti tra le varie città.
D. Ora invece?
R. Pare che su questi temi ci sia un isolamento totale dei singoli individui. A Roma in via del governo vecchio c'era l'università delle donne di Libera, ci incontravamo lì ad ascoltare le colleghe o a dire la nostra. C'era un rete che è indispensabile se si vuole fare politica.
D. Altrimenti il rischio è quello di rimanere in silenzio?
R. Il problema è che oggi posso dire di essere marxista, contro la società, atea, e questo non desta nelle altre persone la stessa reazione preoccupata e sdegnata di quando dico di essere una femminista.
D. Il femminismo è davvero un pericolo?
R. Per gli uomini certamente sì, perché sanno che gli argomenti delle donne, quando sono ben maneggiati, sono inconfutabili, mentre magari anche l'ateismo si può confutare.
D. L'ateismo non mira a diminuire il potere maschile.
R. Pensi che al festival internazionale di Angoulême, tra i finalisti non c'era nessuna artista donna. Dopo le proteste, gli organizzatori ci hanno ripensato. E siamo nel cuore della civilissima Francia.
D. Senza bisogno di andare in Medioriente quindi.
R. No, perché anche da noi scattano meccanismi subconsci, retaggi culturali che diventano automatismi, e su questo si dovrebbe ragionare perché sono prodotti di una socializzazione di un certo tipo ma sono poi talmente ribaditi e mai messi in discussione che diventano automatici e vengono praticati senza che ci sia più un minimo di consapevolezza.
D. Il fatto che negli Stati Uniti forse ci sarà il primo presidente donna della storia potrebbe iniziare a cambiare questo senso di consapevolezza occidentale?
R. Sia l'elezione di Obama che quella di Hillary Clinton sono talmente contro tutta la concezione tradizionale conservatrice dell'America profonda che non potevano non provocare reazioni.
D. Violente, visto il numero di neri uccisi dalle forze di polizia in questi anni.
R. E quella di Hillary potrebbe provocare un recrudimento dell'antifemminismo, non mi meraviglierebbe, ma rimarrebbe comunque un fatto importantissimo a livello storico culturale.
D. Che cosa cambierebbe?
R. Ci sarebbe un tabù spezzato. Non possiamo dare per scontato che d'ora in poi i neri godranno tutti i diritti ma, insomma, hanno avuto un presidente, e così varrà per le donne.
D. Per quello più che un tabù infranto, ci sarebbe bisogno di un miracolo...
R. Intanto si aprirebbe la discussione, la possibilità della rivendicazione, anche del conflitto magari, che non mi spaventa affatto.
D. Che cosa le fa paura invece?
R. Il tabù sacralizzato intoccabile per cui di certe cose non si deve neanche discutere, come la donna papa per esempio. L'idea oggi è talmente assurda e fuori dagli schemi logici che diventa perfino comica.
D. Un'eresia.
R. Si, o il rogo o gli sghignazzi.
D. Ma chissà: le vie del signore sono infinite.
R. Speriamo anche quelle delle signore.
Seconda Invervista a Massimo Cacciari
Massimo Cacciari, filosofo
Colonia, Cacciari: "Le europee cambieranno abitudini a calci. Da deficienti accogliere e basta"
12 gennaio 2016 ore 15:26, Marco Guerra per Intelligonews
“Sempre peggio, almeno per 50 anni, saranno costrette a cambiare stile di vita a calci”. È l’analisi di Massimo Cacciari relativa alle tensioni seguite ai fatti di Colonia contro le donne tedesche. Il filosofo sentito da IntelligoNews parla delle trasformazioni epocali che l’Europa sarà costretta ad affrontare.
In Germania dopo i fatti di Colonia si registrano le prime ritorsioni contro i migranti. Dobbiamo preoccuparci per un’escalation delle tensioni?
“Certo che c’è da preoccuparsi, siamo davanti all’assenza di qualsiasi politica, sia per l'immigrazione sia per l’integrazione, lo scenario si fa drammatico. Le nostre città saranno destinate, se non cambiano le cose, a trasformarsi in un insieme di ghetti, di barriere, di frontiere e di etnie separate con tutte le conseguenze immaginabili”.
Ieri un altro episodio è successo nel salernitano, anche l’Italia non è immune?
“Ma tutto il mondo è Paese dagli Usa all’Europa, dovunque non ci siano politiche di integrazione che funzionano ci sono conflitti fra etnie, culture e persone povere e ricche. Crescendo le diseguaglianze crescono anche le occasioni di conflitto”.
Così, “io ti accolgo punto e basta” non può bastare più come risposta?
“Ma non è mai servito, solo i deficienti potevano crederci, ma non c’è più nemmeno quello. Non c’è una politica che regola l’immigrazione né una politica per l'integrazione, quindi dove pensa che possiamo andare finire?”
Un duro colpo per chi pensava che era possibile la convivenza?
Colonia, Cacciari: 'Le europee cambieranno abitudini a calci. Da deficienti accogliere e basta'“Ma come si faceva a pensarlo, mancando qualunque politica? Come si poteva pensare che le cose potessero funzionare. Finito l’intervallo di misericordia per il bambino morto sulla spiaggia sono tornati identici tutti i problemi, che se non si affrontano si possono solo incancrenire!”
Ma non c’è una questione culturale di fondo secondo lei, un’incompatibilità tra culture diverse?
“Ma che vuol dire? Siamo diversi anche io e lei; se lei muore di fame e io sono ricco a un metro da lei, lei si incazza”.
Ricordiamo anche le guerre alimentate dall’Occidente…
“Ma la storia c’entra poco, se andiamo alle fonti di tutto questo caos arriviamo ai tempi di Esaù, il problema è oggi e oggi manca qualsiasi politica per affrontare queste trasformazioni epocali, e pace all’anima nostra”.
È sciocco continuare a dire come un mantra “non cambiamo il nostro stile di vita”?
“Sono tutte stupidaggini, tutte coglionate espressione di pura ignoranza, i nostri stili di vita sono cambiati mille volte nella storia in base a mutamenti di Stato, catastrofi, cambiamenti sociali e culturali. Nessuno sta fermo, non c’è un modo di vita immobile, sono tutte stupidaggini che vengono da persone ignoranti che sono al governo in Europa. Non esistono più gli Audenauer e i De Gasperi, c’è gentucola sprovvista dei fondamentali per affrontare una cambiamento d'epoca”.
Quindi le donne europee dovranno cambiare alcune abitudini della loro vita?
“Sì, ma una cosa è cambiare perché sai di dover cambiare e governi il cambiamento, un conto è cambiare a calci. Quando cambi a calci i mutamenti sono drammatici”.
Dobbiamo aspettarci nuove episodi come quelli di Colonia e situazioni di tensione?
“Ma sarà sempre peggio, almeno per 50 anni, fintanto che per ragioni demografiche non finiranno i flussi d’immigrazione. Nel frattempo dobbiamo aspettarci sempre peggio”.
Terza intervista a Diego Fusaro
Diego Fusaro, filosofo
Colonia, Fusaro spiega: "Scenario apocalittico. In Occidente per essere eroe oggi devi essere vittima"
13 gennaio 2016 Marta Moriconi per Intelligonews
“Sempre peggio, almeno per 50 anni, saranno costrette a cambiare stile di vita a calci”. Era l’analisi di Massimo Cacciari espressa ieri a IntelligoNews e relativa alle tensioni seguite ai fatti di Colonia contro le donne tedesche. Oggi abbiamo intercettato un altro filosofo, il giovane Diego Fusaro, che con le parole di Martin Heidegger ci parla della “società della notte del mondo, quella in cui siamo precipitati” senza essere “più coscienti del buio in cui siamo”.
Fusaro condivide la riflessione espressa da Massimo Cacciari? Lo stile di vita cambierà e la trasformazione epocale non sarà indolore?
"Sono d’accordissimo con Cacciari. Quello visto in questi giorni è uno scenario apocalittico. Mi ha colpito che in qualche modo il fatto che siano migranti e stranieri, che non andrebbe usato né come giustificazione né come aggravante, invece sia stato trattato come elemento attenuante. E’ paradossale. La logica vorrebbe che venissero trattati come tutti i cittadini. Per alcuni esponenti politici, penso a quelli del Pd, la questione dell’immigrazione viene prima di quella delle donne".
Tutto quel tentativo di ridimensionare quanto accaduto a Colonia, non è comunque inutile?
Colonia, Fusaro spiega: 'Scenario apocalittico. In Occidente per essere eroe oggi devi essere vittima'"Certamente, ma questo è buon senso e non è di casa nel nostro tempo. Aggiungerei una domanda: quelli che fanno sempre le battaglie in difesa delle donne dove sono finiti? Vengono prima le battaglie per i migranti nella scala delle priorità da quanto ho capito...".
E’ mancata una politica d’immigrazione e di integrazione per Cacciari. In compenso c’è stata un’escalation rispetto alle iniziative di dare qualche centinaia di euro a migrante accolto a famiglia. Che succede?
"Diciamo che l’immigrazione ha senso quando arrivano gruppi di migranti che vengono fatti integrare. Quando ne arrivano orde, come in questo caso, di persone non controllate questi fenomeni possono capitare. E comunque non c'è attenuante, cosa che colpisce invece in questa situazione".
Quanto accaduto in Germania, è lo specchio del vecchio conflitto tra ricchi e poveri?
"No, io questo non lo leggo come un conflitto tra ricco e povero, ma un conflitto con i vigliacchi protagonisti. Chi alza le mani su una donna deve avere la pena massima, immigrato o autoctono che sia. Il conflitto tra uomini e donne è impari, è un altro fenomeno".
Se Cacciari parla di scenario drammatico riferendosi al futuro, Fusaro di cosa parla?
"Io parlo di scenario per cui per un verso si limiteranno le libertà in nome della sicurezza, e per un altro verso ci andranno di mezzo immigrati che non fanno male a nessuno, ma che verranno visti come assassini. Poi, mi sento di dire che il buonismo ancora una volta trionferà. Da questa vicenda esce un migrante che si presenta come un nemico totale. E' il caso di ribadire poi che la concezione della donna occidentale - che pure non è perfetta perché ridotta a merce - ha comunque dei vantaggi rispetto a quella di questi signori qua".
E la virilità maschile come ne esce?
"In maniera penosa. Perché intanto dove erano gli uomini tedeschi in quel frangente? Dove era la Polizia tedesca? Mi pare sia una domanda che in maniera onesta vada sottoposta. Vorrei proporre una lettura poi, leggete il libro di Daniele Giglioli "Critica della vittima": la vittima è presentata ormai come l’eroe del nostro tempo nell’Occidente. Ha ragione perfettamente, perché per essere eroe oggi devi essere vittima".
Che tra l’altro si trasforma in carnefice?
"Esattamente".
Una domanda sulla guida senza patente depenalizzata. Basteranno 5000 euro per sanare l’illecito. Soldi contro reati?
"Io userei il caso che ha appena portato come esempio per spiegare a un bambino di 8 anni che cos’è il classismo e la disuguaglianza sociale: è una società dove tutto è possibile a patto che tu abbia i soldi per potertelo permettere. E’ un self service per fare tutto ciò che vuoi perché ogni limite morale viene abbattuto, probabilmente in futuro si potrà anche avere rapporti sessuali con i bambini e chi oserà dire che non è corretto sarà un pedofobo, però dovrai avere i soldi per potertelo permettere. Questa è la società più terribile che si potesse prospettare. Un incubo. Io la chiamerei con Heidegger la società della notte del mondo, siamo precipitati in un buio totale in cui nemmeno siamo più coscienti del buio in cui siamo".